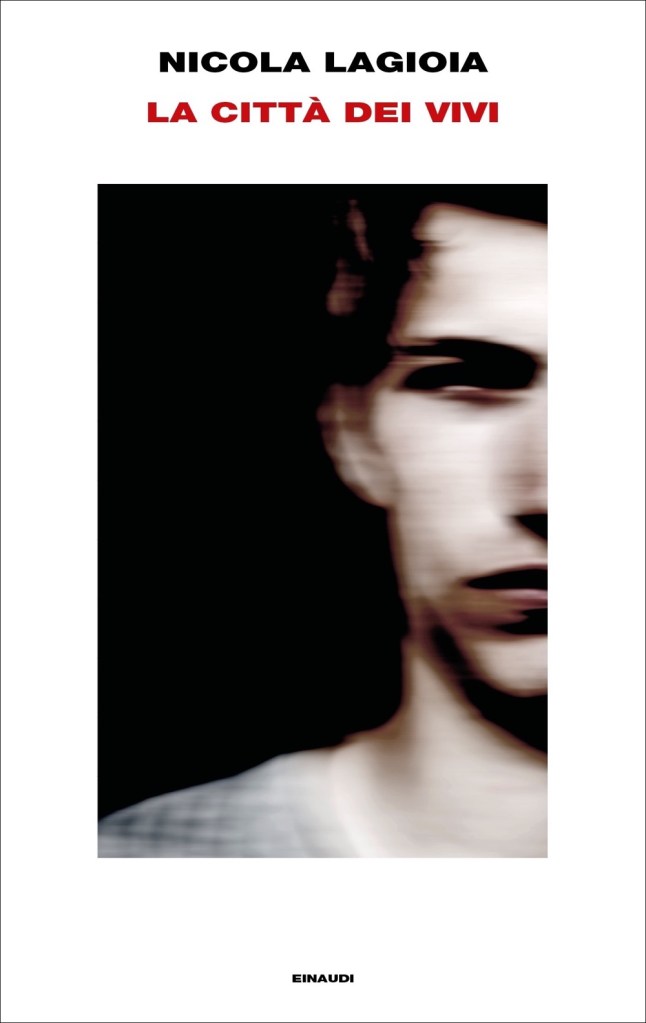La commedia di Jean Giraudoux scritta nel 1943 è di grande attualità, si potrebbe dire che ai suoi tempi sia stata premonitrice di eventi che, nel mentre della scrittura, sembrano irreversibili. Da molti definita una favola ecologica, si può di certo dire che, come il presente, non ha un fine lieto. È una storia che, nel dramma sociale che si consuma, inserisce momenti di ironia amara che strappa sulle prime il sorriso, ma che poi si rivela nel suo significato secondo.
La parte dedicata all’ambiente è, invece, marginale: il discorso esiste, è presente e forse per i tempi era anche all’avanguardia, ma non è un aggettivo che inserirei per contraddistinguerla essendoci tanti punti accennati o meglio sviluppati e un tema grande e universale che è quello della lotta tra bene e male e, ancora più interessante, il confine che c’è tra le due facce quando si parla dell’essere umano. Pregi dunque dello spettacolo, ben riuscito anche nell’interpretazione di tutti gli attori, ma ne avrebbe giovato una minore durata perché il messaggio culturale e politico è chiaro sin dall’inizio quindi molte scene e personaggi di contorno non fanno altro che ribadire quanto già detto. La struttura, lineare e chiara tranne in pochi momenti, non restituisce l’umanità del popolo e la lotta contro chi vuole annientarli. Sembra di assistere a un qualcosa di ottimo dal punto di vista tecnico, ma di scarsa empatia per chi guarda.
Scendiamo ora nel dettaglio di queste due ore di spettacolo.

La scenografia è molto semplice: un tappeto che fa da giardino, tavolini e sedie. Facciamo subito la conoscenza di tre figure in giacca e cravatta, simili in tutto e per tutto a comuni uomini d’affari, seduti al tavolino più appartato: il Presidente (Francesco Migliaccio); il Barone (Mauro Malinverno) e lo Speculatore (Riccardo Maranzana) raccontano la loro tremenda ascesa sempre in onore del profitto a tutti i costi. Questo punto risulta forzato perché sembrano tra loro estranei e ciò che li colloca insieme in quel momento è un mistero. Chiaro, a ogni modo, l’intento di aver bisogno di dare una forma e una sostanza, una faccia, al male. Emblematico e maggiormente d’impatto il racconto dello Speculatore che nella sua carriera si è occupato di sfratti: ricorda in particolare i bambini così attaccati alle loro cose da dovergli spezzare (non lo esplicita se non con un chiaro gesto delle mani) le braccia per staccarli dai giochi e dai letti. Scopriamo finalmente lo scopo di quella triade: fondare di una nuova società che solo e soltanto di profitto si alimenta, con sotterfugi e imbrogli di cui si compiacciono.
Non importano il nome, lo scopo esplicito, la forma di società, meno domande si fanno meglio è per tutti. Un’altra figura, che fino a quel momento era di spalle a bere acqua seduta a un altro tavolino, prende parola. È il Prospettore (Giulio Cancelli), molto simile nell’abbigliamento e nei modi ai tre, che si avvicina mettendo sul tavolo un nome per la società (qui non è chiaro il passaggio dall’essere uno sconosciuto in un bar al ricevere denaro per la sua trovata); poi innesta nel gruppetto di affaristi un’idea, la sua idea: trivellare Parigi, in particolare il quartiere di Chaillot, per estrarre il petrolio e spazzare via la feccia. Intanto, prima e dopo questo momento, altra umanità fa la sua comparsa: Martial il cameriere (Davide Rossi), Irma (Zoe Pernici), il Sordomuto (Jacopo Morra), il Cenciaiolo (Giovanni Crippa) e la Fioraia (Miriam Podgornik), tutti malamente cacciati dai tre. Appare, poi, lei: la pazza di Chaillot. Aurelie (Manuela Mandracchia) vestita di stracci e accompagnata dal suo fido ombrello.
Quando il quartetto di cattivi si allontana, dopo aver minacciato proprio Aurelie di cancellarli dalla terra, inizia a farsi strada il piano per salvare Parigi e il loro microcosmo, simbolo di ogni quartiere e città del mondo che dovrebbe avere la forza di organizzarsi e insorgere, cosa che nei tempi moderni è sempre meno sentita se non in alcune occasioni. Aurelie, ora anziana e probabilmente aristocratica decaduta, vive in un mondo tutto suo dopo essere stata abbandonata dall’amato: non vede i mali del mondo, frequenta le persone del posto che vivono nella semplicità e delle piccole cose belle della quotidianità, le stesse che lei decanta poi a Pierre per convincerlo a non uccidersi.
È un personaggio, quello del pazzo di quartiere, che fa da sfondo in tante narrazioni e che non è scomparso dalle città, portatore di storie e di una qualche verità. A differenza sua, però, gli altri del popolo hanno ancora i piedi per terra e sono proprio loro a rivelarle il piano dei quattro uomini. Intanto che la sua mente cerca una soluzione, altri personaggi fanno la loro apparizione: una guardia (Riccardo Maranzana) chiamato a gran voce dalla stessa Aurelie che ha appena salvato un uomo che voleva buttarsi dal ponte, Pierre (Emanuele Fortunati). A poca distanza di tempo arriva una bagnina (Miriam Podgornik), emblema dei corsi che anche oggi spuntano come funghi soprattutto dalla Rete e che ti promettono di diventare esperto di tutto in poche lezioni. Convinta di poter salvare Pierre dall’annegamento, anche se in acqua non ci è mai caduto, ripete come una macchina tutte le regole del manuale comprese di numero di pagina in cui sono scritte: anche lei, nonostante il suo ruolo positivo da salvatrice di vite, in fondo cerca solo l’approvazione degli altri imparando tutto a memoria, ma senza saperlo davvero mettere in pratica; c’è una differenza con i quattro affaristi ma qui il confine tra bene e male non è così nitido.
La scena cambia. Il prato viene poggiato su un grande tappeto che identifica l’interno della casa di Aurelie. Scopriamo presto il suo piano grazie alla presenza del Fognaiolo (Jacopo Morra) che mostra alla padrona di casa come aprire e richiudere la botola che porta alle fogne. Giungono poi le due care amiche della donna, Gabrielle (Ester Galazzi) e Constance (Evelyn Famà) e danno vita a un siparietto molto allegro, ma troppo lungo, con tanto di cane impagliato che la sua padrona “finge” di portare con sé per compagnia, pur sapendo che il suo è morto, e la presenza di un uomo misterioso ma invisibile. Tra urla e risate scomposte Aurelie riesce a confidare alle due amiche quello che sta per accadere e decidono insieme di metter su un processo simbolico contro tutti quelli che si vendono al Potere e ai Soldi. Il Cenciaiolo è l’accusato che imbastisce uno dei discorsi dei tre uomini di cui all’inizio, togliendosi a un tratto i suoi cenci e mostrandosi in giacca e cravatta, assolutamente convincente tanto da destare dei dubbi sulla sua vera natura.
Il processo termina con una condanna senza appello, ma ora è la volta di mettere in atto il piano: far credere agli affaristi che le fogne sono un ottimo posto per trivellare, quindi li convince a scendere nella botola e lì li rinchiude. Un gesto che nella sua follia giudicheremmo di bontà e di sicura volontà di salvezza, ma siamo sicuri che sia così facile e netta la divisione?
Un enorme rombo risuona: la bomba è scoppiata ed è stato Pierre a farlo, complice da sempre del male. Quel male che non è scomparso con la morte dei quattro, perché come loro ce ne sono tanti altri in ogni luogo, come dimostrano i cloni sulla scena e il “balletto” con risata finale, mentre il sipario si chiude, del Presidente. Hanno vinto loro.
La pazza di Chaillot
di Jean Giraudoux
adattamento Letizia Russo
regia Franco Però
con Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa, Giulio Cancelli, Evelyn Famà, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Mauro Malinverno, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Zoe Pernici, Miriam Podgornik, Davide Rossi
scene Domenico Franchi
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale Mari
musiche Antonio Di Pofi
foto di scena Simone De Luca
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro di Napoli − Teatro Nazionale
lingua italiano
durata 1h 50’
Napoli, Teatro San Ferdinando, 15 marzo 2022
in scena dal 15 al 20 marzo 2022
Pubblicato originariamente su Il Pickwick.
Viviana Calabria