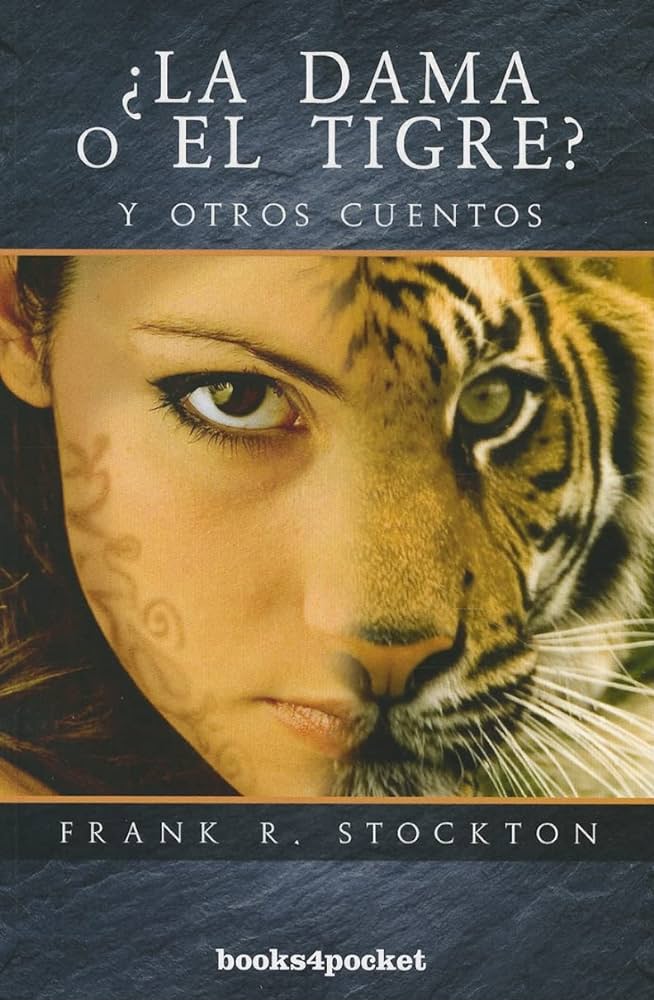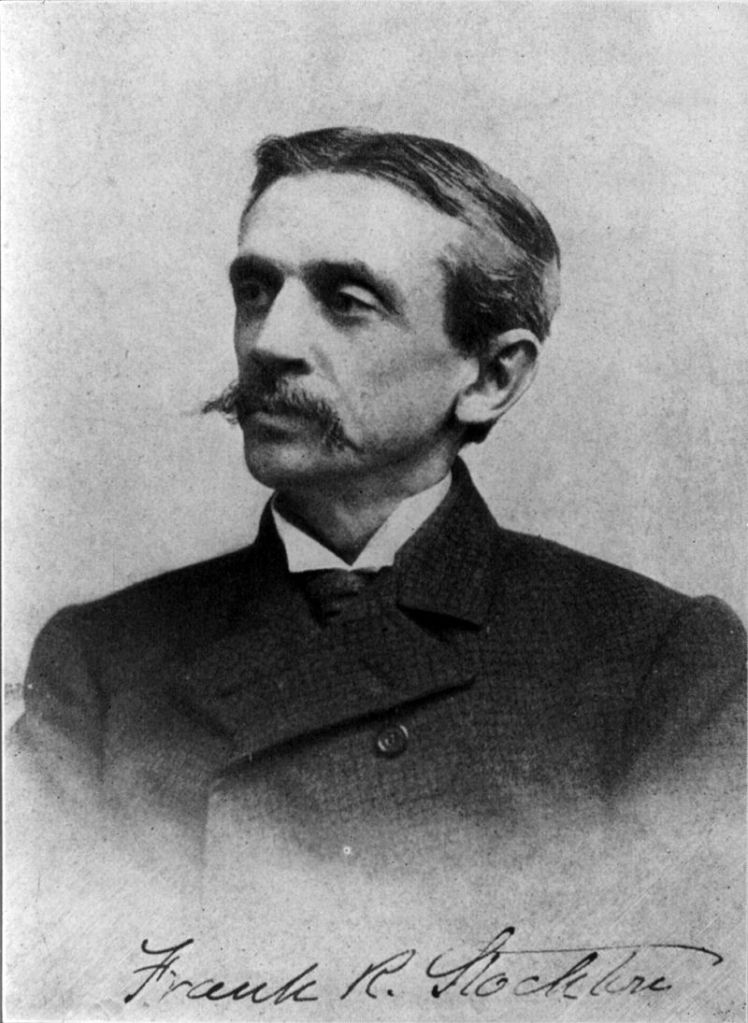Salì al bosco di primo pomeriggio uscendo da Bavena e costeggiando il Parco Regionale dell’Aveto. Subito i sentieri e la vegetazione si fecero fitti. La luce opaca, densa. Nevicava nuovamente dalla tarda mattinata, dopo una sola nottata di sosta. Era la seconda settimana di pace dopo il crocevia dell’esame e l’assunzione. La biologia e le chiacchierate con la natura sarebbero rimaste alla stregua di una saltuaria frequentazione. Al solito, gli era parso d’infatuarsi ma si fermò al secondo volume. Ora qualcosa di impegnativo e duraturo gli avrebbe preso buona
parte del tempo. Pazienza.
I passi divennero più lenti, la pendenza aumentava gradualmente. Il silenzio, morbido. Braccia di neve scivolavano dai rami appesantiti, toccando il suolo con un tonfo spugnoso. Febbraio subentrava a gennaio con passo soporifero. Si chinò a tirare i lacci per stringere un nodo. Vide il biancore spesso della neve sopra il terreno e ne raccolse un pugno dentro il guanto. Era friabile.
Farina. Provò a soffiare e ne volò via una piccolissima nube. L’effetto lo rallegrò. Si sollevò e riprendendo il passo percepì un sospetto dietro sé. Terminò il passo e tenne la gamba davanti rigida per farne il nuovo appoggio. A quel punto si voltò a sinistra per guardare dietro la spalla, quasi immobili gli aghi degli abeti rossi che circondavano lo spettro visivo. Cadde ancora un braccio di neve, da almeno quindici metri, ma a una distanza sufficiente da ammutolirne il tonfo.
Gli parve di non possedere un baricentro totalmente saldo, quindi, prima di voltare di centottanta gradi la testa, riportò lo sguardo diritto innanzi a sé, e con mezzo passo della gamba indietro conquistò un appoggio più ampio. A quel punto non gli fu difficile voltarsi a destra senza l’impressione di cadere avuta un attimo prima. Ma non fu sufficiente a non spaccargli il respiro quando sotto i rami più bassi di un abete innevato lo vide.
Pazienza: che esclamazione ipocrita.
Il grigio a impasto marrone del pelo rammentava una traccia d’autunno al culmine dell’inverno silenzioso e teso.
Perché preferiamo abbandonare un sogno, anziché edificarlo?
Notò che il proprio respiro stava alterandosi.
Dove avrà riposto il primo testo di biologia che gli regalò sua sorella coi soldi di mamma?
Da quanto tempo stava osservandolo, o fu una sorpresa anche per lui?
È una buffonata, in definitiva, optare per un lavoro non amato ma proficuo: lo sapeva da prima di sceglierlo.
Scorta attraverso l’aria umida, la parte grigia del manto pareva quasi verde, ma forse era un’impressione.
Qual è il momento che ribalta il piacere in fastidio, in una storia d’amore, e la fa terminare?
Qualche alito di vento sollevava l’estremità di una ciocca pulita dalla neve.
Quando gli dissero che ci sarebbero voluti giorni per i referti, ebbe paura di non saper aspettare e non sapere aspettare era come cadere.
Gli occhi erano conficcati nei suoi, diseguali, molto chiari, ma uno dei due quasi cristallino.
Era scappato dalla caserma, dall’ospedale, da più di una donna, da almeno due lavori, da molti colloqui e da una prova di canto, dalle interrogazioni, dai bambini più grandi, dagli schiaffi di sua madre.
Percepì un tremore sotto la lingua, si sentì aver paura, ma non sentì la paura.
Al ritorno in ospedale per la diagnosi non avrebbe potuto sentirsi dire nulla di buono perché si accorse di non essersi dato la possibilità, durante tutti quei giorni, di pensare a qualcosa di buono.
Osservava il suo sguardo vigile tra i fiocchi sottili e feroci che gli cadevano innanzi, e ovunque intorno.
Impegnandosi al limite delle sue capacità era stato in grado di ottenere il peggio di quello che aveva immaginato: bravo!
Quando aveva smesso di osservare il resto della boscaglia?
Abbiamo fatto fiorire una letteratura indulgente e prolissa attorno alla questione del momento giusto per compiere un cambiamento, ma è un bellissimo teatro che nasconde la nostra codardia.
Si osservò divenire parte del proprio tormento, specchiato in quegli occhi glaciali e mansueti, e fu lì che intravide, in un’unica sequenza, il tempo sospeso del presente e poi quello smarrito del passato, inchiodato dopo un cammino di due ore e una vita di ventisette anni, in quella spaccatura di secondi che la neve perpetuava in eterno.
Non era questione di fare la cosa giusta, del resto, ma la scelta giusta: perché se ne accorse così tardi rispetto alle scelte già fatte?
Per un istante gli sembrò di respirare odore di zolfo, ma evidentemente era qualcosa d’altro, non sarebbe stato possibile: ma perché nell’accogliere il tremore della paura non si sentì solo?
Era chiaro, aveva mentito a suo padre e a sua sorella, ma la questione se la era rigirata fino a sistemarla, dentro sé, a tal punto d’essersi convinto d’essere pulito: ma non era vero, cazzo!
Nell’urgenza del respiro sfibrato ricordò d’aver letto che talvolta gli avversari – o le prede – tentassero di salvarsi sottomettendosi, schiena a terra: allora tentò di capire se doveva farlo, e se doveva farlo, quando, all’ultimo istante, durante la corsa, durante l’attacco, o adesso?
Scoprì il sesso, senza impararlo, nella sua stanza di ragazzo, toccandosi i tabù che pure un laico come lui avrebbe scoperto, più tardi ancora e con rabbioso stupore, di coltivare.
In quel modo gli avrebbe dato dell’altro tempo per fargli capire che si stava arrendendo, che sarebbe diventato ciò che avesse deciso lui.
Si era innamorato più d’una volta, ma soltanto in una ebbe la certezza di voler diventare un uomo migliore per quella donna.
Rammentò d’aver sentito dire che era da più di cent’anni che venivano attaccate solamente prede animali, o rivali, e non un uomo.
Una delle delusioni più ricorrenti cui dovette fare l’abitudine, negli anni, fu la persistente conferma d’appartenere a una società dedita per lo più a ostentazioni di capacità e simboli vacui ed inesistenti.
Non riusciva a muoversi. Ma è vero, non aveva paura: perché?
Il prossimo viaggio sarebbe stato in Patagonia, in solitaria, non avrebbe più rimandato, era soltanto questione di accumulare le settimane di ferie necessarie.
Eppure quei due occhi diseguali non lo fecero sentire respinto, quell’attesa vitale – o fatale? – gli parve giusta, per la prima volta intuì di non sottostare a un interrogatorio mirato a una conclusione, come in un tribunale degli umani.
Aveva sentito di cadere decine di volte innanzi all’ipotesi della malattia, fino a che non si sollevò nel momento in cui divenne una conferma.
Ebbe voglia di confessare a quegli occhi attenti e randagi cose che non avrebbe rivelato ad alcuno, ma cosa?
La malattia non è un luogo, ma un tempo.
Sembrava una follia, ma quella forma selvaggia e padrona dello spazio e della sua vita che aveva innanzi gli parve di una bellezza abbacinante.
Da anni, la notte sognava di suonare il pianoforte, e una chiesa buia, in bianco e nero, con bellissimi coni di luce bianca provenienti dall’alto.
Se fosse tornato indietro l’avrebbe raccontato?
La Patagonia non sarebbe stato un viaggio, ma una prova.
Si leccò la macchia nera sulla zampa in attesa della morte o della vita dell’altro.
Non bisognerebbe mai confondere un viaggio con una sfida, non bisognerebbe confondere nulla con una sfida.
Per un istante si posò la brezza: neve, solamente, e luce opaca.
Sarebbe giunto fino alla Terra del Fuoco, dove per seimila anni ha vissuto una popolazione autoctona ora quasi estinta che si chiama Yaghan: essi coniarono un termine che da qualche minuto gli frullava nella testa, Mamihlapinatapai, che racconta dell’azione di guardare negli occhi un’altra persona sperando che questa faccia qualcosa che tutti e due desiderano fortemente, ma che nessuno comincia per primo.
La concentrazione mansueta del lupo lo fece sospettare che non abbiamo raggiunto ancora un grado di evoluzione tale da decrittare l’intelligenza del regno animale.
Pensò a suo padre, che gli citava un certo polisindeto di Hemingway per parlargli di letteratura, doveva essere stato felice fino a che si scelse, eppure dovette non esserlo stato più da quando lasciò fare agli altri.
Se fosse morto, che cosa sarebbe rimasto?
Sembrava fosse rimasta in vita una sola donna Yaghan, l’ultima di seimila anni di storia, si diceva avesse oltre novant’anni e stesse compilando un dizionario della loro lingua, lo Yamana, che sarebbe morta assieme a lei.
Pareva pensierosa, la neve che cadeva, ma non lo era affatto.
Quanta parte della vita la trascorse a cercare suo padre in quello che non era.
Un fiocco gli si posò sulla lente sinistra degli occhiali: che fine faranno i padri, nel regno animale?
Madri e padri come dono della vita, e condanna.
Era scappato e aveva mentito decine di volte per questioni frugali, ma lì, con lo sguardo diseguale del lupo immerso nel suo, gli parve rivelatore il fatto di non doversi guardare attorno, di non dover temere trappole nascoste, che la questione fosse interamente davanti ai suoi occhi.
La malattia ci racconta, ma è un esito, non la scaturìgine.
Ricordò d’aver letto nel libro di biologia regalatogli da sua sorella, che l’animale che ora aveva innanzi normalmente si avventa al collo della preda per annullarla con un colpo solo, netto, coi canini ricurvi e i muscoli della mascella che lacerano tessuti, muscoli, carne, e per la preda la morte precipita immediata come con un colpo di fucile.
Fra tre giorni sarebbe stato in città, a quella scrivania, al suo posto, in attesa di maturare quanti più giorni possibile per un viaggio ingiustamente divenuto altro.
Abbassò il muso e annusò la neve.
La leggerezza è una virtù dell’intelligenza.
Poi lo risollevò.
Alla scrivania, al suo posto: quale posto?
Non ne era certo, ma gli parve di intravvedere il vapore acqueo fuoriuscire dal naso dell’animale.
Come si chiama lo spazio simbolico che svuotiamo quando rivendichiamo che è stato solo sesso?
Ci sarà un branco?
In alcun caso è soltanto sesso.
Ne sarà il capobranco?
Terminare amicizie o relazioni è altrettanto imprescindibile che saperle coltivare, negarne il senso è come negare le stesse.
Quanto sarà pesato, quaranta cinquanta chili?
Gli sovvenne un ricordo di Emanuele Severino confessato a un giornale, malinconiche parole rimembravano la moglie malata, con lui durante un viaggio a Cuba: una notte di tempesta il vento ululò contro una vetrata, così che la mano di lei sotto le lenzuola cercò la sua per stringerla, e a lui parve un commiato.
Come un mantra di cui aveva perso il controllo, si ripeteva che il lupo attacca l’uomo sporadicamente, ma ne è minacciato quasi esclusivamente.
Qualcuno ci fa credere costantemente d’essere nella parte luminosa della geografia.
Esistono più libri sul lupo che riguardo a qualsiasi altro animale selvatico.
E nella parte giusta della storia.
Sono animali estremamente sofisticati, con un complesso repertorio di segnali per comunicare tra loro.
Si sorprese pensare quanto fossero belli i loro nomi italiani, tra tutti i ghirigori sull’agenda della reception di Samarcanda, due anni prima. Quelli suo e di sua sorella. Di quanto prevista fu quella notte imprevista d’amore barbaro e rudimentale.
Il capobranco, il maschio alpha, non impartisce ordini, è il branco che normalmente lo segue.
Occorrerebbe tenere in casa, attaccata a una parete dove puntiamo l’occhio almeno una volta al giorno, una cartina rovesciata del mondo.
Pensò che se non fosse stato per il libro di biologia, le uniche cazzate che sapeva sui lupi derivavano da Cappuccetto rosso.
Se in qualsiasi momento sai dove sei e dove stai andando, probabilmente non stai andando da nessuna parte.
Improvvisamente si alzò un vento umido, sentì gocce spesse penetrargli nella pelle attraverso gli strati dei vestiti.
L’età non è sommare, ma dispiegare.
Non si era più mosso, e aveva la sensazione che le sue stesse orme si stessero ricoprendo.
Se potessi ricordarti per sempre – recitò fra sé – penserei alla geografia delle tue vene disegnate sotto la spalla, sopra il seno, alla luce asiatica della lampada da cucina.
Gli occhi del lupo accarezzavano leggeri il peso rarefatto della foresta, osservando ogni cosa, mentre la testa, la mandibola e le orecchie si voltavano indolenti a destra e a sinistra della scena, rigate appena dalla traiettoria della neve.
Cos’è che ci manca, quando ci manca qualcuno?
Per la prima volta da quando lo aveva incontrato, anche lui distolse lo sguardo dallo sguardo del lupo, per poi cercarlo nuovamente.
Eppure è ciò che non conosciamo che potrebbe cambiarci realmente.
È difficile immaginare cosa vede un uomo che osserva un lupo che lo osserva.
Siamo parimenti lontani e vicini alle cose.
La macchia si faceva lentamente più buia.
Cristiano Denanni